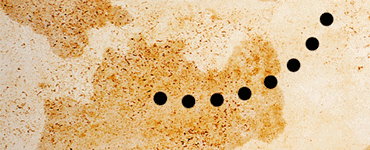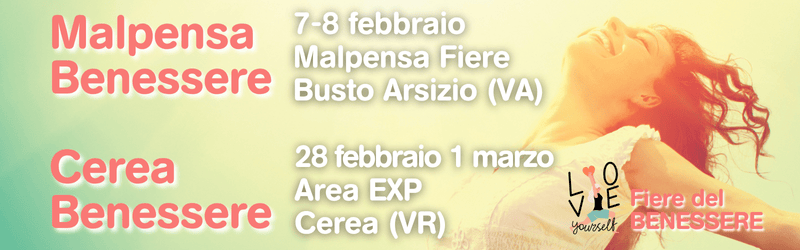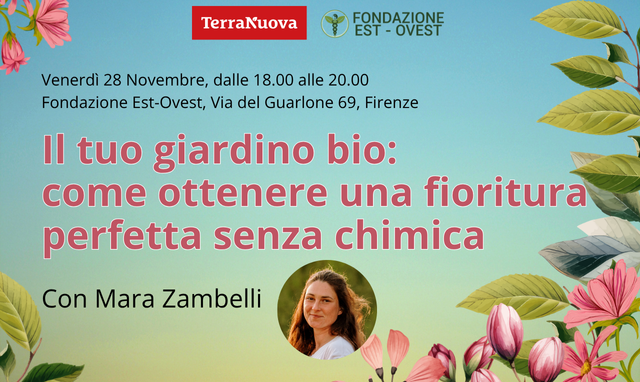Tre anni di studio ed analisi dei dati, 120 aziende valutate da uno strumento ad hoc atto allo scopo, le quattro realtà agricole più importanti d’Europa impegnate in prima linea per un obiettivo comune, azioni di comunicazione e sensibilizzazione relativamente al tema del progetto. Questi gli elementi chiave di AgriClimateChange Life+, ricerca ambiziosa e complessa che punta alla riduzione delle emissioni di gas effetto serra mediante migliori pratiche agricole.
Il progetto ha preso il via nel settembre 2010 per concludersi nel dicembre 2013; al lavoro un team composto da organizzazioni pubbliche e private di Francia, Italia, Germania e Spagna.
Partner capofilala FundacionGlobalNature, un’associazione spagnola impegnata da vent’anni nella protezione dell’ambiente e nella diffusione di pratiche agricole sostenibili; gli altri soggetti coinvolti sono stati l’Associazione tedesca Bodensee Stiftung, che si occupa di favorire lo sviluppo ed il consolidamento di un’economia sostenibile intorno al lago di Costanza, la francese Solagro, punto di riferimento in tema di energie rinnovabili e gestione delle risorse naturali, ela ComunitàMontanaTrasimeno Medio-Tevere, un ente pubblico che promuove lo sviluppo sostenibile del proprio territorio gestendo inoltre il Parco Regionale del Lago Trasimeno.
«Obiettivo del progetto – spiegano i promotori italiani – era individuare, sostenere e promuovere sistemi agricoli in grado di lottare contro il cambiamento climatico, garantendo operatività e redditività del settore. Primo step, la selezione delle aziende da sottoporre al vaglio degli esperti, mediante una serie di audit energetico-ambientali effettuati con uno strumento tecnico denominato ACCTool, un programma basato su Planete, piano di valutazione sviluppato nel 1999 dall’Istituto di ricerca Solagro e già testato in Francia su oltre 3700 aziende. ACCT ha permesso di valutare, in un arco di tempo di un anno e tenendo conto dell’ultima stagione completata, i consumi di energia, nonché le emissioni di gas effetto serra e lo stoccaggio di carbonio di ogni singola azienda».
«Per ciò che concerne il consumo di energia, ACCT ha misurato sia quello diretto non rinnovabile (petrolio, gas, energia elettrica) che indiretto legato ad altri aspetti della stagione agricola (mangimi acquistati, macchinari, fertilizzanti minerali, fabbricati); nel calcolo del ciclo di vita (LCA) sono state infine inserite anche le attività di estrazione, produzione e trasporto – proseguela ComunitàMontanaTrasimeno Medio-Tevere – In merito alle emissioni di gas serra, invece, l’analisi ha interessato, prevalentemente, l’anidride carbonica (CO2), il metano (CH4), frutto dei processi digestivi dei ruminanti (principalmente bovini ed ovini) ed il protossido di azoto (N2O), rilasciato dai terreni agricoli a seguito della trasformazione microbica dei fertilizzanti azotati nel suolo. Diverse le tipologie di produzione analizzate: in Spagna (Regioni di Valencia, Murcia e Tenerife) aranceti, oliveti, riso, aziende produttrici di frutta e verdura; in Germania – Regione del Baden Wurtenberg – sono state prese in considerazione le produzioni di bovini da latte o da carne, e quelle di mele; in Francia – Regioni di Aquitania e Midi-Pyrénées – aziende di allevamento e quelle specializzate in produzioni vegetali; in Italia – Umbria – oliveti, vini DOC, grano, suini e bovini.
I risultati della diagnosi hanno evidenziato una grande variabilità in termini di consumo di energia o di emissioni di GES nell’ambito di uno stesso sistema agricolo; i potenziali di riduzione risultano dunque legati a tali risultati ed evidenziano i diversi livelli di manovra tra le varie aziende analizzate. Quelle con minore consumo energetico, presentano, spesso, potenziali di riduzione più bassi (10%), mentre più consistenti sono quelli delle aziende maggiormente energivore (30 – 40%).
Le misure proposte, invece, hanno riguardato, in parte, l’ottimizzazione delle pratiche colturali e/o di allevamento; in altri casi sono stati necessari investimenti di natura economica (installazione di caldaia a biomassa, impianto di biogas e/o fotovoltaico…); mentre in alcune aziende, gli interventi attuati hanno comportato e comportano, da parte dell’agricoltore, un investimento e controlli temporali costanti (rotazione colturale diversificata, modifiche nel sistema foraggero dell’allevamento, semina diretta). In ogni caso, oltre la metà delle azioni attuate nel corso del progetto AgriClimateChange, è stata il frutto delle opportunità finanziarie messe in atto attraversola PoliticaAgricolaComunitaria (PAC). In generale, la lotta al cambiamento climatico richiederà sostegno finanziario e regolamentazioni specifiche su differente scala (europea, nazionale e regionale), e potrà offrire delle opportunità agli agricoltori in termini di competitività, qualora riescano ad attenuare la loro dipendenza da energie fossili. In tal senso, la riforma della PAC per il periodo 2014-2020, pone l’accento sugli obiettivi di conservazione delle risorse naturali e di protezione del clima; obiettivi che condizioneranno, in termini di sviluppo rurale, una parte dei finanziamenti. Ma se gli operatori del settore avranno l’onere di rendere attuabili migliori pratiche agricole, i consumatori dovranno indirizzare i loro sforzi verso alimenti con bassa incidenza energetica (prodotti freschi e di produzione regionale). Solo così gli sforzi del settore agricolo per uno “sviluppo rurale sostenibile” potranno intensificarsi. Il tutto a vantaggio della collettività».